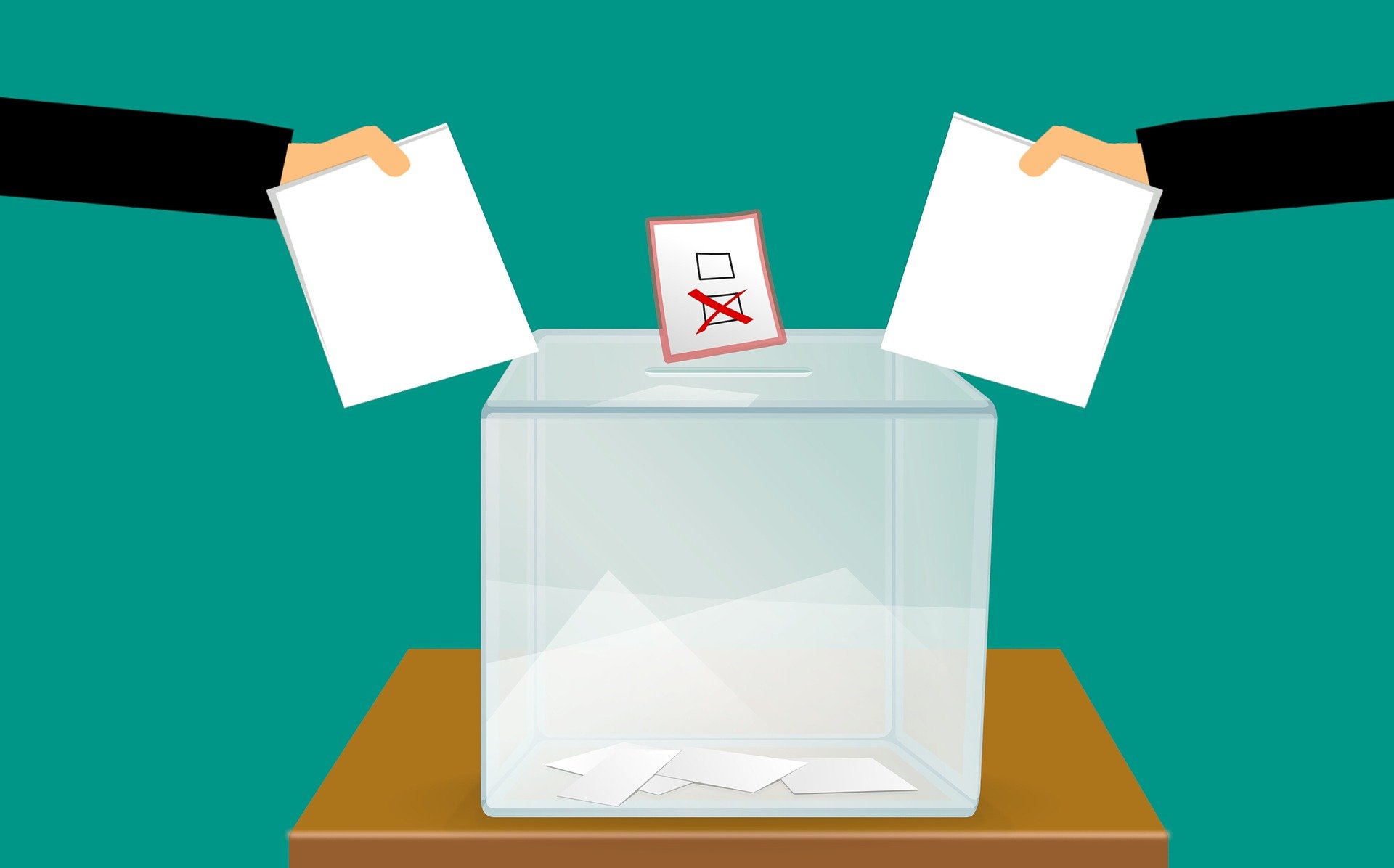Il secondo esempio è legato al celebre scienziato Robert Oppenheimer, leader del gruppo di fisici che realizzò la bomba atomica a Los Alamos, nel Nevada (Progetto Manhattan, 1940-1946). Molti rappresentanti delle nuove generazioni probabilmente non hanno mai sentito parlare di Oppenheimer, ma il film uscito due anni fa – diretto da Christopher Nolan, basato sulla biografia firmata da Kai Bird e Martin J. Sherwin, vincitore di diversi premi Oscar – ha messo in discussione la decisione di sganciare le bombe sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki nel 1945.
A più di 75 anni dagli eventi, il film raccontava anche il graduale cambiamento nella psicologia dello scienziato che supervisionò il suddetto “progetto” per la produzione delle prime bombe atomiche al mondo, le uniche finora utilizzate. Parallelamente agli elogi della critica cinematografica, l’opinione pubblica, stimolata dalla stampa di tutto il mondo, qualificò Oppenheimer come un “genio indiscutibile”, un “eroe di guerra”, ma anche… un “terrorista”. Tutto questo sullo sfondo del conflitto in Ucraina, dove esisteva e sussiste tuttora una minaccia nucleare. Era accaduto anche negli anni ’40 e ’50.
Oppeheimer, il cavaliere vittorioso dalla triste figura
La figura di Oppenheimer – ricostruita, ovviamente in modo soggettivo, dagli sceneggiatori e dal regista sopra menzionati – mostra la complessità dei dilemmi etico-politici – in cui il ruolo delle analisi e dei commenti della stampa è essenziale – laddove chi è chiamato a costruire un’arma in grado di uccidere decine di migliaia di persone. L’alternativa era la continuazione di una guerra con molte più vittime. Inoltre, fino al maggio del 1945, quando il Progetto Manhattan era quasi completato, non si sapeva quale fosse lo stato della ricerca degli scienziati tedeschi nel settore nucleare.
In questo contesto, l’Oppenheimer di Nolan è un personaggio triste che ci invita a riflettere – per alcuni politici, persino a una riflessione etica nel senso sopra menzionato – sulla legittimità delle categorie etiche nella storia e sul modo in cui si trasformano nel tempo. Non dimentichiamo che, dopo la fine del progetto in questione, Oppenheimer divenne una sorta di pacifista, rifiutando l’idea di “diplomazia nucleare”, promossa negli anni Cinquanta e Sessanta da entrambe le parti della cortina di ferro, affermando che “gli obiettivi di politica estera non possono essere raggiunti con mezzi coercitivi”. Il presidente Lyndon Johnson lo aveva riabilitato dopo essere stato inserito nella “lista nera dei simpatizzanti comunisti” dal celebre senatore Joseph McCarthy .
Oppenheimer fu una doppia vittima. In primo luogo, della polarizzazione della stampa – e di conseguenza dell’opinione pubblica – attorno al suo lavoro come leader del gruppo di Los Alamos. In secondo luogo, della sua posizione pacifista e della sua opposizione alla costruzione della bomba all’idrogeno, che per il politico americano, ma anche per l’americano medio, rappresentava un’ulteriore garanzia contro la minaccia sovietica.
Un esempio sovietico…
In un certo senso, la sua situazione ricorda quella di Andrej Zacharov, il leader del gruppo di scienziati che costruì la bomba all’idrogeno sovietica. Quando la consegnarono all’esercito, Zacharov si concesse una serie di osservazioni sulla pericolosità di quest’arma di distruzione di massa. Fu trattato senza pietà e con rispetto dai generali. “L’hai fatto tu – gli dissero – prepotente, ora è il nostro lavoro, sei fuori dai giochi per sempre”. In seguito, divenne anche lui un pacifista e un dissidente, e il regime lo esiliò a Gorkij (Nižnij Novgorod). Lo avrebbero eliminato, ma era troppo… famoso.
Nel caso di Oppenheimer, la stampa ha avuto un ruolo importante nel plasmare il suo destino. Quanto a Zakharov, la stampa nazionale sovietica non è intervenuta a causa della censura del regime, ma la stampa occidentale gli ha concesso ampio spazio e, in un certo senso, gli ha salvato la vita. Ricordo i commenti di Radio Free Europe sulle lettere indirizzate alla redazione dalla moglie di Zakharov, Elena Bonner, che ricevette il Premio Nobel per la Pace al suo posto nel 1975.
Senza la stampa, il caso Watergate non sarebbe esistito.
Uno degli eventi che ha segnato profondamente la vita politica americana, con echi anche ai nostri giorni, il caso Watergate, ha avuto un’importante componente mediatica. Oserei dire che è stato un momento di fondamentale importanza nella storia recente dell’umanità, perché ha dimostrato che le società democratiche, per quanto imperfette, possiedono gli anticorpi necessari all’autoregolamentazione in caso di scivolamenti interni. Nel nostro caso, quegli anticorpi provenivano – come è accaduto in altre situazioni – dalla libera stampa.
Casi simili ci furono prima e dopo il Watergate, ma non si raggiunse mai la portata della vicenda a Washington. I libri scritti su questo episodio in difesa della democrazia americana cercarono di dimostrare che le forze del bene sono al di sopra degli oscuri interessi dei politici e vincono sempre. Lo stesso fece il film “Tutti gli uomini del presidente” di Alan J. Pakula, dove Dustin Hoffman e Robert Redford, nei panni di Carl Bernstein e Bob Woodward, giornalisti del “Washington Post”, interpretarono ruoli memorabili, ma ci sembra di ricordare con più piacere la lezione di recitazione del vecchio Jason Robards, il loro capo nel film, vincitore di un Oscar come miglior attore non protagonista.
In quel periodo, uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti, Richard Nixon, appena rieletto, fu costretto a dimettersi senza mai più tornare in politica, nonostante i suoi tentativi. Di fronte alle prove portate dai giornalisti, dovette ammettere la sua colpa: aveva mentito al popolo americano. L’America non gli perdonò la menzogna, e la stampa si vantò di un grande, anzi storico, successo.
Alcune…conclusioni obbligatorie
Gli esempi sopra riportati appartengono a registri tematici diversi, ma dimostrano che la stampa – in senso occidentale – non è solo una fonte di informazione, ma un punto di riferimento all’interno di una società democratica, un riflettore che illumina il lato oscuro dello spazio pubblico. A volte, a rischio di distorcere la verità, come accaduto nel “caso Oppenheimer”.
Tornando al nostro tema, è fondamentale aggiungere che, a livello teorico, la stampa dovrebbe essere garante della trasparenza e, al tempo stesso, pilastro centrale della democrazia. Il suo ruolo non è quello di decidere per il pubblico, ma di fornire elementi sufficienti affinché il lettore tragga le proprie conclusioni. In pratica, le cose non sono mai così semplici. Ogni scelta di argomento, ogni titolo, ogni immagine rappresenta, di per sé, un suggerimento editoriale. Da qui la complessità del rapporto tra il libero arbitrio del lettore e il ruolo formativo della stampa. Quando la presentazione della realtà è fatta con onestà, i due agiscono in armonia. Quando intervengono interessi della sfera editoriale – anche involontari – il lettore finisce per credere di aver scelto liberamente, mentre in realtà è stato sottilmente guidato verso una conclusione specifica.
Forse più che mai nella recente storia umana, la stampa ha una missione estremamente difficile: informare in un mondo turbolento, mantenere l’equilibrio in uno spazio pubblico frammentato e rispettare la libertà di pensiero del suo pubblico. Non è un compito facile, ma essenziale. Tra l’esigenza di efficienza, le diverse pressioni e le sfide dell’era digitale, i giornalisti devono sempre ricordare a se stessi che, al di là del pubblico e delle tendenze, rimane un valore fondamentale: il rispetto per la verità e per la libertà del lettore di scoprirla da solo .
George Milosan